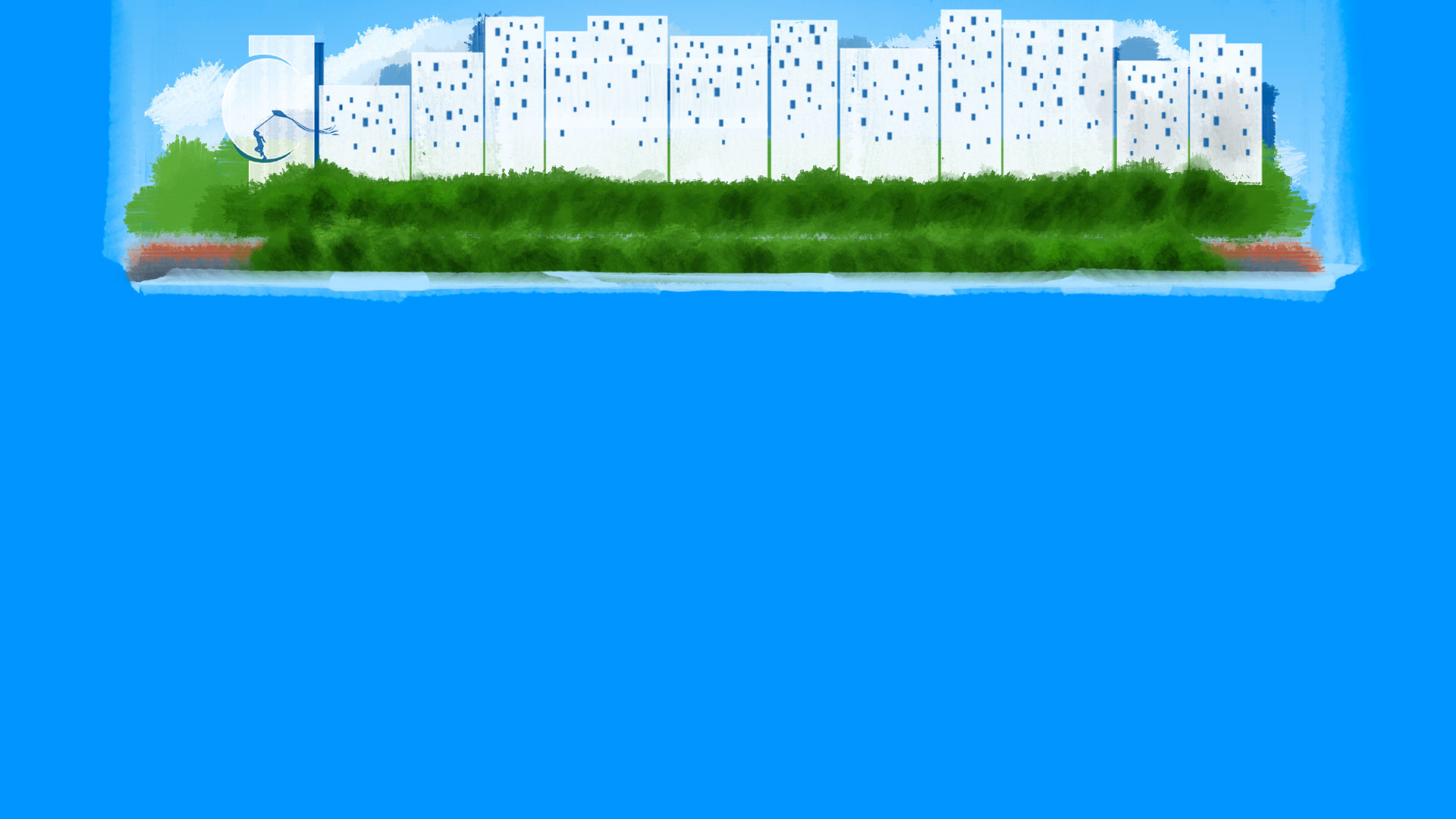E’ necessario che l’educatore sappia nominare le strategie utilizzate per entrare in relazione con il bambino e tenga alta l’attenzione sui suoi bisogni, sulle sue aspettative e desideri.
Patrizia Sordi
Lasciare traccia del nostro passaggio equivale a rendere visibile il nostro lavoro, e di conseguenza ad evidenziare la qualità e la quantità delle risorse esplorate, le criticità, gli errori di valutazione e di intervento, per poter rivisitare il progetto educativo, cambiare rotta, trovare collegamenti e interruzioni; e, alla fine, per poter trasmettere una prassi che in quel contesto, con quel bambino in particolare, con quel tipo di interazione possiamo definire buona: buona prassi
L’educatore scolastico presta la sua professionalità a fianco di minori inseriti in contesto scolastico, quando a seguito di una diagnosi funzionale si ritiene necessaria una “assistenza educativa per le relazioni sociali” (Mod. B/H e Mod. DF – Neuropsichiatria infantile Uompia). Una definizione così ampia e generica non aiuta a chiarire il ruolo, le competenze, i vincoli e l’ambito di intervento. Soprattutto lascia ampio spazio ad interpretazioni personali che di volta in volta e da contesto a contesto assumono contorni differenti.
L’educatore a scuola deve quotidianamente ridefinire i contorni del suo agire educativo in relazione anche alle diverse professionalità presenti. Gli educatori sanno bene come il senso della loro presenza a scuola, sia suscettibile di variazioni a seconda del senso che i docenti danno alla loro presenza e di conseguenza al loro intervento. Uno degli aspetti che caratterizza il lavoro degli educatori nelle scuole, e con il quale è necessario confrontarsi, è la solitudine: nelle scelte educative, nella relazione con i bambini, spesso, nel quotidiano, solitudine nel rapporto con l’istituzione scolastica. L’educatore a scuola non appartiene formalmente ad un’équipe di lavoro: ad un consiglio di classe, ad un collegio docenti. Opera in una relazione individuale con il bambino che gli viene affidato ed è spesso alla ricerca di agganci professionali con gli insegnanti e il ritorno non è sempre soddisfacente.
La solitudine delle professioni educative non è certo un argomento nuovo. Essere soli nella relazione educativa porta con sé una deriva possibile, fonte di autoreferenzialità paralizzante, sia per il bambino che per lo stesso educatore, stretto tra l’incapacità di leggere i bisogni dell’altro (in questo caso del minore ) e la sua difficoltà nel perseguire il cambiamento: porto avanti il mio lavoro, ho una relazione sufficientemente empatica con il bambino, mantengo rapporti corretti con il personale scolastico, con scadenze regolari comunico con la mia organizzazione, alla fine dell’anno stilo una relazione conclusiva.
Praticamente un’isola autosufficiente senza collegamento alcuno, con le altre isole dell’arcipelago “bambino”. E sì, perché il bambino di cui ci occupiamo è spesso oggetto e soggetto di altrettanti interventi e relazioni che non possiamo non considerare in un’ottica di evoluzione e autonomia, nei tempi e nei modi che ciascun bambino può esprimere. Pensare che il nostro agire si esaurisca nel qui e ora dell’intervento individuale è un modo per crogiolarsi in prassi miopi, inefficaci e tutt’altro che educative.